 Sempre di più i morti in guerra sono i civili, soprattutto i più deboli. E’ l’insicurezza alimentare assieme alle disuguaglianze e socio-economiche che portano alla guerra e non la diversità etnica o religiosa (articolo pubblicato sulla rivista “Amici di Follereau” di dicembre)
Sempre di più i morti in guerra sono i civili, soprattutto i più deboli. E’ l’insicurezza alimentare assieme alle disuguaglianze e socio-economiche che portano alla guerra e non la diversità etnica o religiosa (articolo pubblicato sulla rivista “Amici di Follereau” di dicembre)
“Cibo di guerra” è il quinto rapporto sui conflitti dimenticati realizzato dalla Caritas Italiana in collaborazione con le riviste Famiglia Cristiana e Il Regno. Oltre al naturale riferimento all’evento di Expo a Milano, sono tre i motivi per cui si è scelto di dare questo taglio alla ricerca come dice Paolo Beccegato, vicedirettore della Caritas e curatore del libro: ”Il legame tra la fame del mondo e la guerra è evidente; la guerra comporta la distruzione di raccolti, una minore produzione. Poi c’è un altro aspetto, ovvero l’uso che si fa della fame per distruggere il nemico e la strumentalizzazione degli aiuti umanitari. Infine, anche se molti dicono che la fame non conduce alla guerra, è però vero che la povertà estrema, la recessione economica e le disuguaglianze socio-economiche portano proprio lì”. E quest’ultima affermazione viene confermata anche da un dato che emerge dalla ricerca: il 90% delle guerre che si sono svolte dopo il 1945 ha riguardato paesi poveri.
Ma cibo da guerra sono anche gli stessi uomini in conflitti che sempre più coinvolgono la popolazione civile, conflitti che si “alimentano” di esseri umani per poter proseguire.
Di che guerra parliamo?
Non stiamo certo parlando di guerre di eroi, Achille ed Ettore non si affronteranno mai più, non sono più i guerrieri a morire in guerra ma i bambini, le donne, i vecchi: “L’impatto della guerra sulla popolazione civile è andato via via crescendo – spiega Paolo Beccegato – negli anni ‘50 il rapporto tra morti civili e morti militari era di 0,8 poi è salito a 1,3 negli anni ’60 (13 civili contro 10 militari), negli anni ’70 e ’80 il rapporto era diventato 3,1, negli anni ’90 8,1 per via dei grandi genocidi dei laghi d’Africa e nei Balcani”.
Si parla addirittura di guerra post-eroica e questa definizione la si può comprendere a fondo leggendo libro Esecuzioni a distanza del giornalista statunitense William Langewiesche, dove si racconta la storia di un cecchino e quella di piloti di droni militari. Si tratta di vere e proprie esecuzioni rese possibili da una tecnologia bellica molto avanzata che permette di uccidere come in un video gioco e quindi senza sensi di colpa (apparentemente).
Gli studiosi per poter confrontare le violenze nel corso del tempo si sono dotati di una classificazione che permette di definire meglio le guerre a secondo del loro grado di violenza. La ricerca della Caritas si basa, oltre che per i dati raccolti, anche sulla metodologia dell’Heidelberg Istitute for International Conflict (HIIK), che definisce cinque categorie di conflitto: dispute, crisi non violente, crisi violente (e da questa in poi si comincia a morire), le guerre limitate e le guerre.
“Dato che oggigiorno non ci sono più dichiarazioni di guerra – afferma Beccegato – è stato deciso che una guerra è tale quando raggiunge un certo numero di morti all’anno”. Questo numero è 1000.
Quante sono e dove sono
Con la fine della Guerra Fredda e la caduta del Muro di Berlino c’è stata l’illusione che le guerre nel mondo sarebbero diminuite, “ E, in effetti, il numero delle guerre del mondo è diminuito dall’ ’89 fino al 2005-2006 – afferma Beccegato – poi la situazione cambia e il numero di guerre riprende a crescere e con esse anche il numero dei morti. Non bisogna però dimenticare che gli anni ’90 furono anni di meno guerre ma con tanti morti tra i civili”.
E oggi com’è la situazione? Il Conflict Barometer dell’HIIK ci dice che nel 2014 ci sono state nel mondo 21 guerre che hanno coinvolto 16 paesi, mentre tutti i conflitti (violenti e non violenti) sono stati 424. Nel 2011, anno in cui c’è stata l’ultima ricerca della Caritas, le guerre erano 20, 14 i paesi coinvolti e i conflitti totali 388. Quindi negli ultimi 4 anni la violenza organizzata è aumentata del 9%, in particolare sono aumentate le crisi violente del 19,6%.
Anche le persone uccise in guerra ogni anno stanno aumentando: “Dal 2003 al 2012 mediamente – precisa Beccegato – c’erano 21 mila morti, nel 2012 sono diventati 38 mila ma dobbiamo escludere dal conteggio la Siria che ha avuto più di 250 mila morti”.
Tutti i conflitti avvengono all’interno dello stesso Stato (eccetto il caso della perdurante crisi tra India e Pakistan); non ci sono più Stati in guerra tra loro.
La metà delle guerre (quelle “vere”) nel mondo sono combattute nel continente africano (Libia, Nigeria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centro-Africana e Uganda), a seguire l’Asia (Afghanistan, Iraq, Israele, Pakistan, Siria, Yemen). Infine c’è la guerra in Messico (contro i narcos, la criminalità organizzata) e in Ucraina, la guerra verso cui l’Europa è forse più sensibile.
Viviamo in un mondo dove le relazioni internazionali sono diventate molto più fluide, nel senso che non esistono più due o tre attori principali che decidono l’avvio di uno stato di guerra o una sua soluzione, ma tanti centri di potere. La recente guerra in Siria, forse la più grave crisi umanitaria dal secondo dopoguerra, ne è un esempio. Contro le norme del diritto internazionale la Siria è oggi bombardata da Stati Uniti, Russia, Turchia, Francia, Gran Bretagna, ognuno seguendo i propri interessi politici e di sicurezza.
Fame e guerra
Le capacità tecnologiche dell’uomo permetterebbero ampiamente la produzione di cibo per tutti e anche le carestie dovute a fatti naturali sarebbero gestibili. Quello che non si può gestire è la fame provocata dalla guerra. Del resto basta fare un po’ di memoria storica delle più gravi carestie del secolo scorso per rendersi conto di come dietro a queste ci siano situazioni di violenza.
Tra il 1917 e il 1919 persero la vita 9 milioni di persiani a causa della guerra tra turchi e russi sul loro territorio. Nel periodo dal 1932 al 1933 in Ucraina a causa del sequestro dei raccolti da parte dell’Armata Rossa (una guerra civile dunque) morirono tra le 7 e le 10 milioni di persone. Nel 1967 la Nigeria impose un blocco alimentare alla regione del Biafra che voleva rendersi indipendente (1 milione di persone morte in 4 anni). Nel 1984-1985 la carestia in Etiopia causata dalla guerra civile (1 milione di morti). Infine tra il 1998 e il 2004, durante la guerra nella Repubblica Democratica del Congo, sono stati poco meno di 4 milioni i morti causati dalla mancanza di cibo.
Ad ogni modo se è assodata la constatazione che la guerra porta alla fame, non si può però affermare l’opposto. Anzi la sottoalimentazione grave, dato che indebolisce l’organismo, porta piuttosto all’inedia della popolazione e alla sua mancanza di reazione (e in questo caso si può parlare della fame come arma). Piuttosto è l’insicurezza alimentare, in aggiunta alla disuguaglianza sociale, che porta alla rivolta, del resto le primavere arabe sono proprio iniziate a causa dell’aumento del prezzo del cibo di base, come il pane.
Gli aiuti umanitari come arma di guerra
Nel 2008 Linda Polman scrisse un bel libro (L’industria della solidarietà), chiaro e documentato, su come gli aiuti umanitari nelle zone di guerra possano diventare una vera e propria arma per i vari contendenti. “Non ci sono regole e accordi sui confini etici – scrive la Polman – e le Ong non decidono dove intervenire in base a considerazioni di carattere etico, ma alla disponibilità di contratti dei donatori”. In questo modo possono crearsi delle situazioni paradossali come quella del campo umanitario a Goma nella Repubblica Democratica del Congo (allora Zaire), dove l’esercito hutu, massacratore di civili, si era ritirato di fronte alla vittoria dell’esercito tutsi e là si era riorganizzato gestendo gli aiuti umanitari per i propri fini.
Uno studio statunitense del 2014 afferma che in un paese dove la guerra dura da molto tempo e così pure gli aiuti umanitari, questi possono peggiorare il conflitto e più precisamente che un aumento del 10% dell’aiuto alimentare provoca un aumento della conflittualità dello 0,7%. Questo naturalmente non può essere un freno per gli aiuti umanitari che devono comunque arrivare. Curiosamente questo dilemma contrapponeva anche due famosi operatori umanitari internazionali, Florence Nightingale e Henri Dunant. Il secondo, fondatore nel 1863 della Croce Rossa Internazionale, era convinto che gli aiuti si dovessero portare ad ogni costo, a differenza della Nightingale per la quale invece gli aiuti servono a poco se come effetto hanno quello di prolungare la guerra.
La spesa per le armi non conosce crisi
Non conosce la parola recessione l’apparato industriale delle armi; sembra strano che riescano a stare assieme gli sforzi internazionali per evitare le guerre e un mercato della vendita di armi sempre più fiorente, eppure questa è la situazione.
Secondo l’ultimo rapporto del Sipri (Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma) nel periodo 2010-2014, rispetto ai 5 anni precedenti, la spesa per le armi convenzionali è aumentata del 16%. I maggiori esportatori sono Stati Uniti e Russia (il 58% delle esportazioni globali) e avanza al terzo posto la Cina che così supera Germania, Francia e Regno Unito. Da notare però che le vendite cinesi di armi sono aumentate del 100% nel medesimo periodo.
Chi acquista più armi? L’India ha aumentato le importazioni del 140%, l’Arabia Saudita del 300%; tra il 2005 e il 2014 le importazioni in Africa sono aumentate del 45%.
Nel dicembre del 2014 è entrato in vigore il Trattato Internazionale sul commercio di armi convenzionali che pone delle precise regole secondo cui è possibile vendere le armi solo in quei paesi dove siamo rispettati i diritti umani. Il Trattato è ancora in una fase “intenzionale” visto che paesi decisivi come Stati Uniti e Cina ancora non l’hanno ratificato.
Un altro dato importante è chi fra i paesi già potenti si sta armando di più. Russia e Cina dal 2004 al 2013 hanno raddoppiato. Gli Stati Uniti invece, nel periodo 2008-2013, hanno diminuito di due punti le spese militari, si deve però tenere presente che la spesa militare statunitense rappresenta ben il 36,1% delle spese militari mondiali dandole una supremazia schiacciante.
Chi si arma di meno è l’Europa che nel suo insieme nel 2014 ha speso il 7,7% in meno dei livelli su cui si era impegnata a fare 5 anni prima.
I mass media e la guerra
Chi conosce la decennale guerra dei Karen in Myanmar? Siamo proprio sicuri che sia dovuto a motivi religiosi lo scontro tra miliziani animisti anti-balaka e i musulmani Seleka nella Repubblica Centroafricana? Le nuove generazioni sahrawi riprenderanno le armi contro il re del Marocco?
Chi in Italia è informato su queste situazioni conflittuali? Pochissime persone, dato che i mass media italiani sono tradizionalmente poco interessati alle notizie di carattere estero. Parlano dei conflitti che sono vicini al nostro paese, o che riguardano direttamente la nostra comunità, conflitti che comunque possono colpire il pubblico italiano perché hanno storie forti, immagini impressionanti da mostrare. Comunque l’interesse mediatico italiano rimane molto limitato e se poi una guerra è lunga o è complicata da spiegare – perché non c’è mai in una guerra una parte buona e una cattiva – allora meglio semplificare il racconto e abbandonarlo dopo un po’.
Anche a livello internazionale i media funzionano secondo una precisa logica: se c’è una buona disponibilità d’immagini, se sono presenti alcuni elementi che danno valore alla notizia (alto numero di morti, occidentali coinvolti, storie strazianti …) allora le agenzie stampa internazionali (Ap, Reuter, Tass, Upi, France Press …) mandano i loro giornalisti e la guerra riesce ad arrivare alla conoscenza dell’opinione pubblica, in caso contrario non esiste semplicemente.
In realtà è sempre più importante il posto dato all’informazione da parte dei belligeranti. Si parla da diversi anni di Information war, una sorta di guerra combattuta con informazioni a proprio uso per scoraggiare l’opinione pubblica del nemico o per influenzare positivamente l’opinione pubblica mondiale. Le tecnologie digitali per comunicare rendono ancora più importante questa componente ma anche più difficile da gestire. La propaganda è sempre esistita ma i video pubblicati (e visibili su Youtube) dall’Isis riescono oggi ad avere un impatto che non ha uguali nel passato.





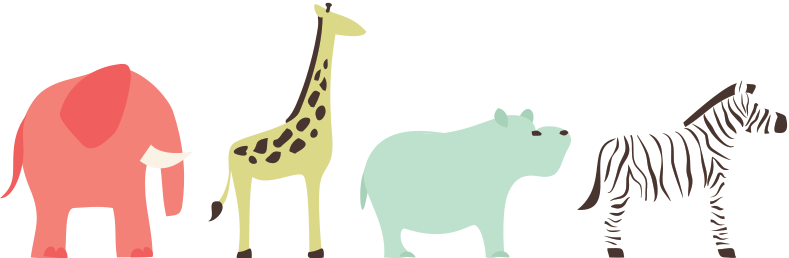




 La
La 
 Tanti i temi affrontati nel numero di dicembre da
Tanti i temi affrontati nel numero di dicembre da  “Mentre correva con il giavellotto in alto, mentre allungava il braccio ben dietro il corpo mentre lo riportava in avanti per rilasciare il giavellotto in alto sopra la spalla – e poi lo rilasciava come un’esplosione -, ci sembrava invincibile”. L’atleta invincibile è Bucky Cantor, il protagonista del romanzo di Philip Roth “Nemesi”. Bucky è un istruttore di ginnastica e si occupa di un gruppo di ragazzi nell’estate del 1944 quando un’epidemia di polio sta investendo la comunità di Newark, una città poco distante da New York. Finirà anche lui ammalato e semiparalizzato e in più con un senso di colpa per non aver saputo proteggere i suoi ragazzi. Negli anni ’40 non c’era ancora il vaccino contro la paralisi infantile (viene chiamata anche così), arriverà solo negli anni ’50 e s’imporrà quello realizzato da
“Mentre correva con il giavellotto in alto, mentre allungava il braccio ben dietro il corpo mentre lo riportava in avanti per rilasciare il giavellotto in alto sopra la spalla – e poi lo rilasciava come un’esplosione -, ci sembrava invincibile”. L’atleta invincibile è Bucky Cantor, il protagonista del romanzo di Philip Roth “Nemesi”. Bucky è un istruttore di ginnastica e si occupa di un gruppo di ragazzi nell’estate del 1944 quando un’epidemia di polio sta investendo la comunità di Newark, una città poco distante da New York. Finirà anche lui ammalato e semiparalizzato e in più con un senso di colpa per non aver saputo proteggere i suoi ragazzi. Negli anni ’40 non c’era ancora il vaccino contro la paralisi infantile (viene chiamata anche così), arriverà solo negli anni ’50 e s’imporrà quello realizzato da 
 Il fumetto in Africa arriva con i colonizzatori. Oramai sono parecchi gli autori autoctoni che trattano nelle loro tavole di temi con una chiara impronta sociale. Intervista a Sandra Federici, direttrice di ”
Il fumetto in Africa arriva con i colonizzatori. Oramai sono parecchi gli autori autoctoni che trattano nelle loro tavole di temi con una chiara impronta sociale. Intervista a Sandra Federici, direttrice di ”
 Gerard Salou durante l’estate raccoglie per 10 ore al giorno i pomodori; dovrebbe guadagnare circa 8 euro l’ora ma alla fine della giornata in tasca gliene rimangono solo 25. I soldi che mancano se li sono presi i caporali che fanno da intermediari tra i padroni dei campi e i lavoratori. Negli ultimi anni si è anche aggiunta la figura del “caponero”, un intermediario che conosce la lingua dei lavoratori stranieri, ma il risultato è sempre lo stesso: lo sfruttamento del lavoratore che molto spesso lavora con un contratto semplicemente finto.
Gerard Salou durante l’estate raccoglie per 10 ore al giorno i pomodori; dovrebbe guadagnare circa 8 euro l’ora ma alla fine della giornata in tasca gliene rimangono solo 25. I soldi che mancano se li sono presi i caporali che fanno da intermediari tra i padroni dei campi e i lavoratori. Negli ultimi anni si è anche aggiunta la figura del “caponero”, un intermediario che conosce la lingua dei lavoratori stranieri, ma il risultato è sempre lo stesso: lo sfruttamento del lavoratore che molto spesso lavora con un contratto semplicemente finto.
 Leggendo on line i maggiori quotidiani in questi ultimi giorni mi domando se chi scrive gli articoli e, ancora di più, chi compone le pagine, decide gli ingombri, i titoli e le immagini, si rende conto di quello che sta facendo. Sto parlando di questa sussurrata guerra alla Libia che vedrebbe l’Italia in un ruolo centrale. Sono tante notizie, anche di natura diversa ma che convergono tutte in una sola voce che da sussurro diventa grido.
Leggendo on line i maggiori quotidiani in questi ultimi giorni mi domando se chi scrive gli articoli e, ancora di più, chi compone le pagine, decide gli ingombri, i titoli e le immagini, si rende conto di quello che sta facendo. Sto parlando di questa sussurrata guerra alla Libia che vedrebbe l’Italia in un ruolo centrale. Sono tante notizie, anche di natura diversa ma che convergono tutte in una sola voce che da sussurro diventa grido. Non solo lotta alla lebbra ma anche all’aids nei progetti che Aifo realizza in Mozambico. Tutto questo in collaborazione con le Ong locali (articolo pubblicato sulla rivista
Non solo lotta alla lebbra ma anche all’aids nei progetti che Aifo realizza in Mozambico. Tutto questo in collaborazione con le Ong locali (articolo pubblicato sulla rivista  Recentemente ho visto un film (
Recentemente ho visto un film (










 to fondato nel 1822 da un gruppo di coloni afro-americani che ritornavano “liberi” dagli Stati Uniti e volevano fondare una nuova nazione, cosa che poi avvenne nel 1847. La stessa bandiera liberiana è identica a quella degli Stati Uniti ma di stelle dorate ne ha solo una. La sua non è certo la storia di uno stato democratico “felice” dato che le guerre civili (1989-2003) ne hanno distrutto l’economia e ucciso centinaia di migliaia di persone.
to fondato nel 1822 da un gruppo di coloni afro-americani che ritornavano “liberi” dagli Stati Uniti e volevano fondare una nuova nazione, cosa che poi avvenne nel 1847. La stessa bandiera liberiana è identica a quella degli Stati Uniti ma di stelle dorate ne ha solo una. La sua non è certo la storia di uno stato democratico “felice” dato che le guerre civili (1989-2003) ne hanno distrutto l’economia e ucciso centinaia di migliaia di persone.


