L’intervista non è recente, l’ho realizzata nel 2011, ma parecchie osservazioni fatte da Massimo Ghirelli, consulente per la comunicazione dell’Unità tecnica Cooperazione del Ministero degli affari Esteri, sono valide e da sottoscrivere. L’articolo fa parte di una monografia pubblicata sulla rivista Hp-Accaparlante intitolata “Make development inclusive – Quando la cooperazione allo sviluppo si occupa di disabilità nei paesi poveri”.
Che ruolo ha o dovrebbe avere la comunicazione per le Ong e per tutti coloro che fanno interventi nei paesi in via di sviluppo?
Più che una questione d’importanza è una questione di necessità. Sono migliaia purtroppo gli esempi di cooperazione, anche buona, che non raggiungono i loro scopi perché non viene tenuto conto in maniera giusta e completa l’aspetto comunicativo. Ti faccio l’esempio di un intervento che facemmo in Niger con i Tuareg che riguardava la costruzione di un ospedale. Non avevamo pensato che in Africa le donne non vanno in ospedale e che quindi, se non si faceva un lavoro d’informazione e di comunicazione, spiegando per quale motivo ne valeva la pena (per ragioni di infezione, igieniche…), tutto sarebbe rimasto lì come una cattedrale nel deserto.
Ma fuori dell’edificio c’era un grande parcheggio che era stato trasformato dai famigliari dei pazienti in un villaggio di capanne. Tutto questo era ovvio e naturale: non avevamo pensato al fatto che mai in Africa una donna sarebbe stata lasciata da sola in ospedale e che quindi, attorno a quella persona, ci sarebbero state intorno tante altre persone diverse che, venendo da lontano, avrebbero poi dovuto fermarsi a dormire lì. In quei casi perciò o fai una stanza comune o, come è stato fatto, adibisci a dormitorio il parcheggio. Questo è stato un caso lampante di mancanza di comunicazione adeguata.
Nell’ambito della cooperazione la comunicazione è sempre stata vista e molto spesso ancora oggi viene trattata come un argomento di secondo livello e quindi considerato un di più, una cosa marginale e perciò, ancora peggio,qualcosa che si fa nel momento in cui il progetto è fatto e finito, a volte confondendolo con una parolaccia come “visibilità”, che di per sé non sarebbe una parola sbagliata, nel senso che bisognerebbe far vedere quello che si fa ma che in realtà viene intesa solo come buona immagine di quello che si fa nella cooperazione italiana. La visibilità spesso non ha nulla a che fare con il buon progetto, la visibilità non è comunicazione. Fino a non molto tempo fa questa parte era considerata molto marginale dalle Ong.
È anche vero che le Ong, stando più vicine al territorio ed essendo espressione di parti della società civile dovrebbero avere ancora più ragioni per capire e per utilizzare una buona comunicazione, per informare prima di tutto i donatori del territorio e le persone che vi partecipano. Le Ong, inoltre, avendo per controparte società civili o piccoli villaggi, comunque non solo istituzioni, dovrebbero fare in modo che questi interlocutori capiscano bene e che soprattutto siano loro a comunicare qualcosa su quello che si aspettano, su come vedono il progetto e su come lo vogliono gestire.
Nel mio lavoro spesso mi sono trovato a mettere delle pezze a progetti in cui c’era una piccola quota riservata alla comunicazione e a convincere gli altri che costituiva invece una parte integrante del progetto. Questo è un elemento raramente compreso, le Ong un pochino ci sono arrivate ma non tutte e soprattutto non ci è arrivata l’istituzione.
La nostra Direzione si è dotata di Linee Guida per la comunicazione; una volta consistevano in un manuale su come si fa la targa, su cosa deve esservi scritto, l’adesivo e tutto il resto; un po’ abbiamo superato questa ipotesi ma anche le Linee Guida attuali, sono solo un punto di partenza per cominciare a parlare di altri aspetti. La comunicazione, per cominciare, deve essere fatta in entrambi i luoghi da parte di vari partner, in patria, e da parte del cosiddetto beneficiario, beneficiario che deve essere partner anche della comunicazione e quindi avere gli strumenti per comunicare. I progetti devono avere non soltanto la partecipazione ma anche il consenso sociale senza il quale il progetto non ha senso.
I progetti stessi in molti casi dovrebbero essere intesi come progetti di comunicazione e non come la comunicazione rispetto ai progetti, sono due cose diverse: i progetti di questo tipo ancora abbastanza rari. Si potrebbe cambiare in questo modo l’intero sistema delle comunicazioni dei paesi in cui si attua il progetto, dalla formazione dei giornalisti alla legge sulla stampa e così via.
Al momento sono in atto progetti di questo tipo? Voi ne curate qualcuno?
Ce ne sono ma si contano sulle dita di una mano. Ho seguito un centro di documentazione per un sindacato di comunicazione in Sud Africa ai tempi della fine dell’apartheid e più recentemente la ristrutturazione di un’agenzia palestinese, la Wafa, un’agenzia stampa che all’epoca era una specie di servizio stampa di Arafat che aveva sede a Gaza e ora ha sede a Ramla. Abbiamo fatto anche un media center, in collaborazione con le Ong e con l’Arci a Belgrado, in una situazione complicata come i Balcani. Negli ultimi anni questi progetti vengono appoggiati anche dai direttori delle UTL (Unità Tecniche locali). In alcune UTL, ho scritto dei progetti come “Comunicare la comunicazione”, quindi intesi proprio per far questo, come riuscire a comunicare bene e chiedersi: “Che strumenti ha l’UTL per farlo?”. Di qui la necessità di dotarsi di un sito, mettere insieme i donatori, le Ong e gli altri partecipanti in rete, in discussione, per comunicare quello che si fa e per farli partecipare e anche organizzare mostre, eventi sulla cooperazione.
Adesso in Palestina si sta lavorando, dopo tre anni di attività, alla terza fase del progetto “Comunicare la comunicazione” e a Gerusalemme, finalmente, si faranno dei corsi di aggiornamento per giornalisti. In un paese particolare come quello di Israele, si tratta di operare per dare degli strumenti soprattutto per lottare, per avere una legge sulla stampa più aperta, considerando il fatto che i giornali possono essere chiusi in qualsiasi momento.
In generale c’è ancora pochissimo attenzione sulle possibilità di stampa e televisione indipendenti. Lo stesso vale per l’Iraq, dove non c’è un UTL ma c’è la Task Force Iraq, organizzazione, il nome lo fa capire, che prima era militare-civile mentre adesso, da qualche anno, è completamente nelle mani della nostra Direzione Generale alla Cooperazione allo Sviluppo. La Task Force, soprattutto in questa fase, in cui si sta piano piano pensando di lasciare il paese, deve raccontare quello che sta facendo e ha fatto. Si tratta comunque di progetti di grande interesse in una situazione difficile come quella della guerra. Progetti di capacity building,di comunicazione interna, progetti che vanno a formare le istituzioni locali, progetti di patrimonio culturale, ambientali, tutta una serie di progetti in cui la comunicazione ha un ruolo centrale. Anche lì, se non c’è consenso, partecipazione e conoscenza dei fatti nulla può funzionare.
Per quanto riguarda il privato sociale, le Ong, ci sono casi di progetti di comunicazione analoghi a quelli che hai elencato?
Ci sono ma sono abbastanza rari. Alcune Ong hanno un buon impianto comunicativo, come il Cesvi di Bergamo, che nasce proprio con una grande vocazione alla comunicazione. Fanno un lavoro sulla comunicazione notevole sia di comunicazione rispetto ai progetti, sia nel modo di presentarli. Un altro che si occupa molto di comunicazione sia in Italia che all’estero è invece il Cospe di Firenze che è diventato un punto di riferimento nazionale per ciò che riguarda media e intercultura, media e immigrazione.
Se tu dovessi realizzare un piano di comunicazione in occasione di un progetto in un paese in via di sviluppo che riguarda, mettiamo, l’inclusione di bambini disabili all’interno di una scuola, come ti muoveresti?
Intanto la prima cosa che farei è inserire la comunicazione nel progetto, cercando di farla entrare a ogni livello, come parte consistente e sostanziale e che sia economicamente supportata. E’ necessario poi che ci siano le competenze necessarie per portarla avanti, quindi le risorse umane e che non si riduca l’attività alla semplice dicitura “attività promozionali”.
Occorrono poi delle azioni preventive, come quelle di allertare la società di cui si fa parte e i partner più importanti che sono nel nostro paese e nel nostro ambito, non soltanto per avere più fondi ma soprattutto per avere quel consenso di cui si parlava. E poi ci sono una serie di input importanti non soltanto economici che poi ricadranno sul progetto e che ci serviranno per preparare le basi di quello che sarà il ritorno di visibilità.
Un esempio di questo tipo è rappresentato dal Magis, un’Ong dei gesuiti italiani, che ha lavorato in Albania con i non udenti anche attraverso il teatro. Gran parte del successo di questo progetto è stato quello di portare in Italia lo spettacolo di questi ragazzi. Ecco questo è un esempio di comunicazione nel senso più normale del termine. Solo che a queste cose ci si pensa dopo, a progetto finito, raccontando solo i risultati e questo non basta. Sia perché sono finiti i fondi, sia perché ti accorgi che non avevi fatto la giusta documentazione, che non avevi fatto le riprese video, scattato le foto. Bisogna quindi inserire la comunicazione in tutte le fasi del progetto e fare il modo di garantire la sua sostenibilità.
La sostenibilità di un progetto, poi, in quanta parte è sostenuta dalla comunicazione? In larghissima parte! I materiali di quel progetto se non vengono curati sono semplicemente i distillati di una relazione che nessuno si legge, che non leggono nemmeno le ONG.
La comunicazione invece va inserita all’interno del progetto, è uno degli elementi fondanti, a tutti i livelli, pensando prima di tutto all’ownership, alla partecipazione democratica di tutti, dei donatori che capiscono effettivamente che cosa stanno donando, senza tuttavia proporre argomentazioni patetiche.
Questo lavoro di comunicazione va fatto prima, durante e dopo il progetto, per costruire un ambiente prima di tutto non ostile, poi consenziente; per poter ricevere un aiuto da parte di tutte le agenzie possibili, di tutte le istituzioni e anche della società civile che è possibile coinvolgere.
Faccio un altro esempio. Ho un amico che ha delle belle idee e mi ha chiesto una mano per scrivere un progetto sulla conservazione della musica africana finanziato dall’Istituto sonoro nazionale. Quando ho letto il suo progetto, mi sono accorto che non aveva messo niente su che cosa si sarebbe fatto con tutto il materiale raccolto. Invece quello che poteva venirne fuori era una cosa bellissima; una mediateca di musica tradizionale africana, fatta attraverso una ricerca nei paesi, a contatto con la gente, frutto di registrazioni, quindi anche un lavoro antropologico importante. Il prodotto finale poteva diventare così una mediateca in Italia e nel paese d’origine.
Dobbiamo far vivere quello che abbiamo e pensare anche a come può vivere dal punto di vista della comunicazione questo progetto, che materiali ne emergono, chi ne è coinvolto.
Da qui si parte. Dopo bisogna fare una scelta e capire come in quel paese si comunica. Tutto questo deve essere studiato prima per capire quali possono essere gli strumenti giusti da utilizzare e naturalmente capire il linguaggio con cui devi parlare alla gente. Comunicazione vuol dire anche questo: farsi capire. Per questo è importante conoscere non solo gli strumenti altrui ma anche i loro codici e lavorare molto su quello.
C’è un bellissimo progetto che ha molto a che fare con quello di cui stiamo parlando; è un progetto che è stato sostanzialmente seguito da un ragazzo, Guido Geminiani, che è stato per un certo periodo un cooperante in Uganda in cui c’è uno dei più grandi ospedali dell’Africa, fatto da una coppia di medici occidentali, al confine con tre – quattro paesi. Questo ospedale è diventato importantissimo e ha una storia molto bella e drammatica perché lì ci furono le febbri emorragiche; prima la moglie e poi il marito morirono proprio perché si erano infettati curando i malati.
Qui quello che sono riusciti a fare, è stato di africanizzare completamente l’ospedale; dai medici all’ultimo degli infermieri sono tutti africani e oggi questo ospedale ospita qualcosa come cinquecentomila persone all’anno. Accoglie anche, in un apposito settore, bambini non accompagnati, anche lì centinaia, migliaia e qui si parlano moltissime lingue. Il ragazzo di cui ti parlavo è stato uno dei primi a lavorarci e ha inventato, in collaborazione con i dirigenti dell’ospedale, un modo per comunicare nonostante la diversità delle lingue. Devi pensare che lì spesso la gente rimane e ci vive, è così l’ospedale è diventato una città. Con quale lingua allora comunicare? E soprattutto come fai l’informazione? Hanno fatto così uno studio sulla segnaletica e sul codice per cercare di trovarne uno comune, basandosi sulle storie, i costumi, le mentalità diverse, la concezione diversa di comunicazione e di spazio, il tutto per arrivare a fare una segnaletica “esperantica”, capace di arrivare a tutti quanti.
 Quando il cinema si occupa di personaggi che hanno a che fare con il mondo dell’aiuto umanitario, questi personaggi tendono a diventare, nei copioni delle sceneggiature, degli eroi un po’ maledetti, oppure dei sognatori; hanno commesso qualche colpa cui devono rimediare o ne commettono ancora, nonostante l’aiuto che danno al prossimo. Insomma sono tutti personaggi estremi, tesi, mai personaggi normali, come di fatto sono la maggior parte degli operatori umanitari.
Quando il cinema si occupa di personaggi che hanno a che fare con il mondo dell’aiuto umanitario, questi personaggi tendono a diventare, nei copioni delle sceneggiature, degli eroi un po’ maledetti, oppure dei sognatori; hanno commesso qualche colpa cui devono rimediare o ne commettono ancora, nonostante l’aiuto che danno al prossimo. Insomma sono tutti personaggi estremi, tesi, mai personaggi normali, come di fatto sono la maggior parte degli operatori umanitari.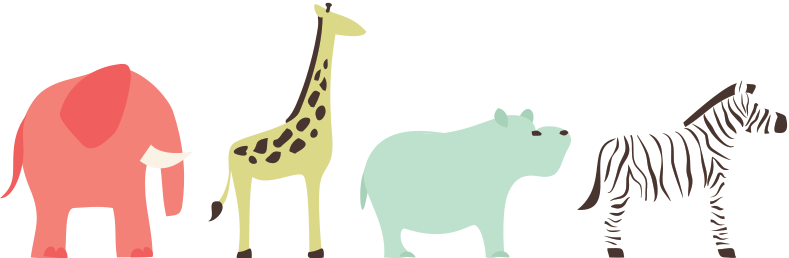
 Recentemente Tarcisio Arrighini, uno dei fondatori della ong bolognese
Recentemente Tarcisio Arrighini, uno dei fondatori della ong bolognese 

 La busta che ho trovato questa mattina nella buca delle lettere presentava su un lato un primo piano di una bella bimba che sorride. I tratti somatici, capelli castano chiari, pelle piuttosto bianca, occhi grigio-azzurri, potrebbero essere quelli di una bambina italiana, qualcuno insomma di vicino a noi. L’elemento che la differenzia da una compagna di banco di una nostra figlia sono i capelli spettinati, attorcigliati (e anche quegli occhi che riflettono troppa luce, l’unica nota che inquieta il nostro sguardo).
La busta che ho trovato questa mattina nella buca delle lettere presentava su un lato un primo piano di una bella bimba che sorride. I tratti somatici, capelli castano chiari, pelle piuttosto bianca, occhi grigio-azzurri, potrebbero essere quelli di una bambina italiana, qualcuno insomma di vicino a noi. L’elemento che la differenzia da una compagna di banco di una nostra figlia sono i capelli spettinati, attorcigliati (e anche quegli occhi che riflettono troppa luce, l’unica nota che inquieta il nostro sguardo).




 Nel
Nel 








